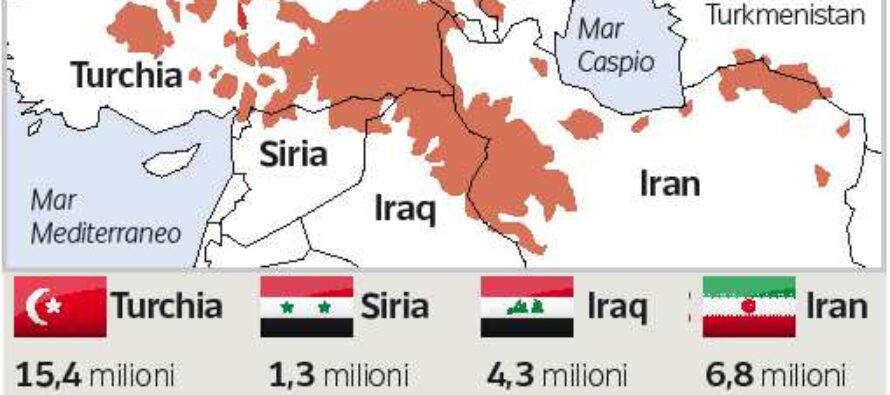Così, a ridosso dell’ecatombe di Ankara, sono venuto a Diyarbakir. C’era ancora il coprifuoco dentro le mura. Dall’aeroporto all’albergo si passava da viali di barricate, roghi, ragazzi che si battevano e colonne di blindati, e soprattutto gas appestanti. Dovevo tuttavia ricaricare il telefono e un ragazzetto dall’aria sveglia, evidentemente rassegnato all’interruzione degli scontri, mi ha offerto i suoi servigi: a gesti, perché io in curdo sono di pochissime parole, e in turco di quasi nessuna. Ma ci si intendeva, e l’ho scritturato a farmi da guida. Si chiama Hasan, ha 14 anni, e abbiamo trascorso insieme parte dei giorni a venire — al calar della sera aveva da fare.
Sono i ragazzi a battersi nelle città dell’Anatolia curda. La prima notte ci sono stati spari e raffiche e qualche colpo di mortaio, poca roba. Di mattina, prima dell’appuntamento con Hasan, sono passato dall’ufficio del turismo. C’erano due signore, mi hanno dato una mappa, ho chiesto quanti turisti ci fossero in questo periodo, mi hanno scrutato per bene, poi hanno detto: “Uno”.
Hasan sarebbe la migliore delle guide se non avesse una sua testardaggine. So anch’io che qui c’è una specie di guerra, ma voglio vedere la Ulu Cami, la Grande Moschea — il quinto luogo sacro dell’Islam. Mi accompagna di malavoglia, rimane nel cortile: ci siamo io e un altro anziano che fa le sue preghiere. Fu già chiesa a san Tommaso, moschea dal 639. Il minareto è in restauro, colonne e capitelli traforati sono mirabili, vado su e giù a piedi scalzi sui 60 metri di tappeto rosso, come in una libera ora d’aria. Hasan viene a tirarmi fuori, ha le sneaker coi lacci ma le sfila e reinfila come fossero ciabatte. Ha fretta di trascinarmi dentro vicoli sempre più stretti, che curvano a gomito. Andiamo quasi di corsa, benché lungo il cammino si incontrino edifici seducenti: tanto ci torno, penso. Leggo i nomi, la chiesa caldea di sant’Antonio, la moschea dello Sheikh Mutahhar — ma il Minareto lo vedo, e carezzo una delle quattro brevi colonne su cui è drizzato. Per la gran chiesa armena di Surp Giragos, san Gregorio Armeno, l’accesso è sbarrato, ed è stata colpita anche lei. A ogni snodo gli abitanti hanno scavato fosse e alzato muri di sacchi di cemento da 50 chili e grosse pietre. Tutto a Diyarbakir è fatto di basalto nero: i monumenti che voglio vedere io e le barricate che vuole farmi vedere Hasan. Questi vicoli sbarrati da cui a volte occorre retrocedere fanno un vero drammatico labirinto. Sostiamo dove uomini anziani stanno seduti su seggioline basse mentre donne lavorano a sgomberare. Hasan mi parla come se lo capissi, e moltiplica i gesti; fa parlare anche gli anziani, e fa grandi cenni di conferma di quello che dicono. Tutti indicano energicamente la direzione che porta, scoprirò fra poco, a un’altra moschea. Sono tristi, arrabbiati e cordiali: Hasan mi presenta come turista italiano, e italiano qui suona bene.
Entriamo in qualche porta, sono case povere e devastate, fanno segno di non togliere le scarpe. Cercano di riafferrare bambinetti che corrono da ogni parte, offrono il chai, e raccontano. Il tono degli uomini anziani ha qualcosa di fatale, come di una sciagura che hanno visto tante volte e che si ripeterà sempre — dicono la parola “barbar”. Il tono delle donne è diverso, come di una sciagura che deve finire, prima o poi, e più prima che poi. Annoto nomi di strada: Yogurt Pazari, Biyikli Mehmed Pasa, Direkhane. Entriamo nelle botteghe sui vetri frantumati, abbassano le saracinesche per mostrare gli squarci dei proiettili: le avevano chiuse pensando di proteggersi. Un vicoletto, discesi pochi scalini, costeggia il cimitero sul lato della moschea, è colmo di detriti e ramaglie, e si apre di colpo allo slargo della facciata.
Hasan, che nell’ultimo tratto mi ha tirato addirittura per mano, indica e non parla, ma la sua faccia dice: “Guarda! Te l’avevo detto o no?”. Guardo infatti la larga facciata della moschea di Fatih Pasha. («Fu costruita fra il 1516 e il 1520 su una precedente chiesa armena. È famosa come Kursunlu Cami, per la cupola ricoperta di piombo…»). È letteralmente crivellata. C’è un viavai di persone, si raccolgono ai finestroni sfondati, fotografano, piangono. Sulla viuzza d’uscita anche le case sono crivellate. In una senza più porta c’è una famiglia radunata, in piedi, in mezzo alla devastazione, come se non sapessero da che cosa cominciare, da dove ricominciare. Dicono cose, Hasan annuisce energicamente, spiega anche a loro che io sono italiano e non capisco niente. Allora una signora giovane mi fa segno di aspettare, va dentro e torna con una sedia sfondata, e la butta in strada, rientra e torna con un rilievo in rame di quelli che si appendono alla parete, è forato e contorto, lo butta in strada. Torna di nuovo e ha in mano fotografie strappate: le mostra e questa volta non le butta via. Hasan sta più zitto, mi guarda, probabilmente vuole capire l’effetto della sua visita guidata.
Un altro giorno dice che la mattina non può venire. Chiedo se deve andare a scuola, sostiene che la scuola è chiusa. Nelle scuole la lingua curda è vietata, qui dove l’Hdp, il Partito dei Popoli di Selahattin Demirtas che a giugno fece fallire il disegno presidenziale di Erdogan, prende quasi l’80 per cento. Me ne vado al museo archeologico, proprio al centro della cittadella, alta sopra la valle del Tigri e i verdi giardini. C’è l’edificio forse più suggestivo, già chiesa armena di san Giorgio, poi hammam, poi niente. Al museo l’impiegata è contenta di strappare almeno un biglietto, cinque lire turche, un euro e mezzo. La collezione è preziosa: ci sono tre enigmatiche figurine stilizzate da Körtik Tepe, di clorite intagliata, corpi di ape e teste di cane o di capra (?).
I reperti di 14mila anni fa servono a prendere le distanze dalle sventure di oggi — forse. A Hasan servirebbe forse accorgersi di come gli umani già allora fossero assetati di sangue reciproco e costruissero abitazioni e utensili per offendere e difendere: homo homini lupus .
Ora è stata premiata la fotografia di una volpe rossa che ha scannato una volpe bianca: Hasan ha una coda bianca, e di notte fa già la sua guerra. Il prossimo giro guidato va oltre, a Hasirli Mahallesi, il rione di Hasirli. La strada si chiama Bahce Sokak, via del Giardino. Il 12 ottobre, terzo giorno del coprifuoco, Helin Sen, 12 anni, era uscita a cercare del pane, i poliziotti cecchini hanno mirato alla testa. Andiamo lungo le mura, qui più diroccate. Al posto del cammino turistico che altrove le costeggia c’è una stradella disgraziata con toppe d’erba e monnezza presidiate da gatti e galline, devono aver concluso un armistizio a scapito dei topi.
È una parte poverissima, le case sono poco più che baracche, l’unico vezzo è una mano d’intonaco di colori accesi. Le persone dentro le mura sono 15mila, ma l’area più coinvolta negli scontri, Baglar, Sehitlik, Peyas, ne tiene 200mila. Sono i più poveri, inurbati negli Anni ’90 quando l’esercito turco bruciava case e villaggi. Ora qualcuno vorrebbe evacuarli, fare il doppio affare della ristrutturazione e della dispersione di una roccaforte della resistenza. Il comune — che ha, come tutte le municipalità curde, due co-sindaci, uomo e donna —ha un piano per risanare e farli restare, ma «da quando è ricominciata la violenza non siamo in grado di occuparci d’altro». Il coprifuoco si è ripetuto già per tre volte da giugno, e molti abitanti hanno cercato riparo da parenti. Così si svolge la campagna elettorale. Raccontano che in questa “operazione antiterrorismo” ci sono state altre vittime dei tiratori, un uomo che sul tetto dava da mangiare ai suoi colombi, una donna incinta.
La strada per il Ponte dei Dieci Archi, “i dieci occhi”, sul Tigri, passa lì sotto, quando ci andiamo in taxi Hasan si accanisce a discutere in mio favore il prezzo, già bassissimo. Il ponte è vuoto, se non per una coppia di adolescenti che si accostano e si respingono nella bella schermaglia. Al ritorno prendiamo il tè in un cortile. La città dentro le mura, invisa ai turchi, si chiama Sur, come una nostalgia d’Argentina, e per giunta i giovani del locale hanno messo una canzone che inneggia al Che. Quest’America Latina spaesata e i saluti a pugno chiuso dei bambini e la prodezza di Hasan mescolano presente passato e futuro come nel gioco delle tre carte: chissà quale vince.