Contro la legge del più forte. L’introduzione al nuovo Rapporto sui diritti globali
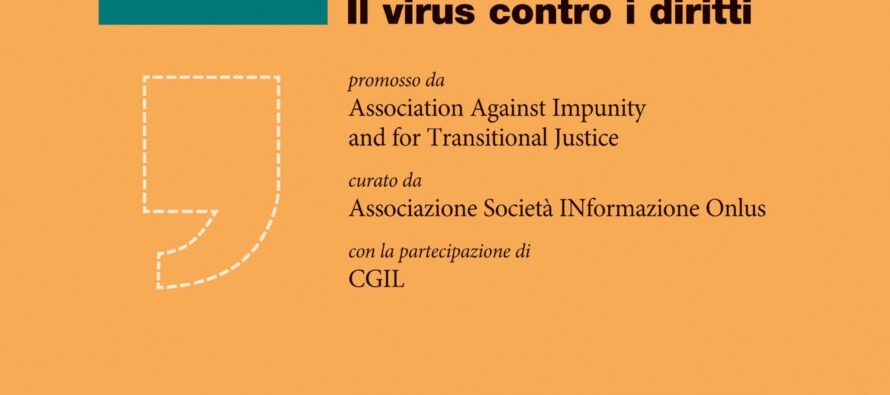
![]()
Anticipiamo qui sotto alcuni paragrafi della introduzione di Sergio Segio al 18° Rapporto sui diritti globali – Stato dell’impunità nel mondo, dal titolo “Il virus contro i diritti”. Il libro, realizzato da Società INformazione, promosso dall’Association Against Impunity and for Transitional Justice (AITJ), con la partecipazione di CGIL, è in uscita nell’edizione italiana per Ediesse-Futura.
L’edizione internazionale, in lingua inglese, è invece pubblicata da Milieu edizioni (già disponibile anche in e-book).
Entrambe saranno presentate online venerdì 11 dicembre, all’indomani della Giornata mondiale per i diritti dell’uomo:
- la versione italiana del Rapporto è al centro dell’incontro alle 15 sulla pagina Facebook e sui siti dirittiglobali.it e collettiva.it, cui partecipano tra gli altri Moni Ovadia e Paolo Rossi;
- alle 9 a Bruxelles, al Parlamento Europeo, l’edizione internazionale viene presentata dalla presidente della sottocommissione Diritti umani Maria Arena, che firma una delle prefazioni del Rapporto. L’evento potrà essere seguito qui:

*****
INTRODUZIONE. Contro la legge del più forte
__________
Sergio Segio
curatore del Rapporto
- Diritti globali vs impunità
Dopo 17 anni, e altrettante edizioni, il Rapporto sui diritti globali cresce ed evolve, con l’edizione principale che diventa internazionale e viene pubblicata in lingua inglese. Un’aspirazione, per la verità, che avevamo avuto dall’inizio di questa avventura editoriale, rimasta sinora nel limbo delle intenzioni e anche delle necessità, essendo del tutto naturale e coerente che l’arco di questioni da noi trattate e analizzate dovessero trovare una conseguente traduzione in uno strumento veicolabile e utilizzabile in diversi paesi, a partire dalla dimensione europea. Il proficuo incontro e collaborazione con l’Association Against Impunity and for Transitional Justice (AITJ) hanno reso finalmente possibile tradurre in pratica quell’intento.
Da questa sinergia origina anche la maggiore focalizzazione del nostro lavoro sui temi dei diritti umani e dell’impunità. Una questione, in evidenza, oggi più centrale, nella misura in cui la crisi del multilateralismo e il dilagare di nazionalismi e populismi stanno implicando uno svuotamento della democrazia e dei suoi istituti e un indebolimento del diritto internazionale e dei suoi strumenti. Ne è derivato, e lo vediamo tragicamente tutti i giorni, un dilagare di crimini di guerra, di aggressioni territoriali e marittime, di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona, di repressioni sempre più generalizzate e ingiustificate nei confronti di cittadini o di intere collettività, il più delle volte nell’impotenza delle istituzioni sovranazionali.
Assieme, vediamo approfonditi, senza adeguate resistenze e reazioni, altri crimini che violano e compromettono diverse sfere di diritti altrettanto fondamentali, che riguardano le comunità e non solo gli individui, come quelli ambientali, economici, sociali. Crimini che si possono definire di sistema, conseguenti a scelte politiche di governi che piegano a interessi particolari i beni comuni e l’interesse generale dei popoli, laddove gli stessi governi sono spesso espressione più o meno diretta di quegli interessi. La globalizzazione neoliberista ha generalizzato e reso più acuti questi processi e più distruttive le loro conseguenze.
Si può dire che, per molti versi, l’umanità sia posta davanti a un bivio: da un lato, si palesa sempre più una catastrofica prospettiva dove prevale la legge del più forte – così forte che piega il diritto e le norme alle proprie esigenze, facendone carta straccia quando occorre, ma anche scrivendo da sé le leggi che trasformano la sopraffazione in diritto; dall’altro, emerge prepotente la necessità di rimettere al centro i diritti fondamentali di tutti e di ciascuno, a cominciare da quello alla vita e alla dignità, ristabilendo a livello globale regole e istituti democratici capaci di tutelare i più deboli, le vittime dei crimini, le popolazioni e le comunità sottoposte all’aggressione e alla minaccia di quei poteri globali irresponsabili e rapaci – privati e statali – che in questi decenni sono apparsi vincenti e che hanno condotto il pianeta e chi lo abita vicino a un punto di non ritorno ambientale e di collasso umanitario.
Per noi questo significa globalizzare i diritti: costruire un diverso futuro di giustizia ambientale, sociale, economica. Per farlo, la lotta all’impunità è snodo dirimente e attuale. A cui, quindi, con la nuova veste e attenzioni del nostro Rapporto, intendiamo portare un contributo di informazione, analisi e proposta.
- La piramide sociale e la pandemia diseguale
Non è forse casuale che questo cambiamento avvenga adesso, nel 2020. Nel momento in cui, con l’emergenza epidemica e sanitaria, tante certezze si sono incrinate e tanti nodi sono venuti al pettine, aggiungendosi a un quadro globale che già sommava crisi a crisi, disequilibri a disequilibri, ingiustizie a ingiustizie. E che impone, più che in passato, una riflessione sui paradigmi dello sviluppo, sui cambiamenti necessari, appunto radicali e di sistema.
È stato un anno duro e difficile. Per tutti, si è letto e detto spesso. Ma non è del tutto vero. Le diseguaglianze abissali, cresciute negli scorsi decenni, si sono approfondite ulteriormente durante la pandemia da coronavirus. Diseguaglianze economiche, con decine, e in prospettiva centinaia, di milioni di nuovi disoccupati e di impoveriti a livello mondiale. Diseguaglianze di salute, con differenti livelli di esposizione e di possibilità di cura in base al censo. Diseguaglianze culturali e sociali, che incidono sulla percezione del rischio e sulle modalità di farvi fronte. Diseguaglianze che, complessivamente, influiscono negativamente sul presente e sul futuro di una parte significativa, per non dire maggioritaria, dell’umanità.
Il periodo della pandemia è stato poi sicuramente più duro per le donne, con percentuali ancora più elevate di violenza domestica e indici più elevati di perdita del lavoro. E, naturalmente, più pesante per gli anziani, in alcune zone decimati non solo e non tanto dalla malattia quanto da scelte sanitarie e sociali sbagliate, oltre che da cronici abbandoni, da strutture di solo contenimento, da un’assistenza insufficiente, da politiche di welfare, a seconda dei paesi, inesistenti o scientificamente (e cinicamente) deteriorati da decenni di privatizzazioni e messa sul mercato dei servizi sanitari e di cura.
In troppe aree e situazioni si salva solo chi può in termini economici, chi ha una buona assicurazione privata, chi vive di rendita e non di pensione o di reddito da lavoro.
La recessione conseguente alla pandemia ha aggravato tali situazioni e tendenze. Ma vi hanno contribuito anche le politiche di contrasto al virus e le scelte di chiusura operate dai governi […] .
Non sono però solo i blocchi delle attività ad aver penalizzato i più deboli, ma anche le scelte in apparenza opposte, di sottovalutazione del problema o di ritardi nell’affrontarlo. La mortalità da Covid-19 negli Stati Uniti, ad esempio, mostra un profondo divario tra popolazione bianca e no. Il tasso di mortalità degli afroamericani è stato pari a 88,4 decessi ogni 100.000 persone contro il 73,2 degli indigeni americani, il 40,4 dei bianchi, il 54,4 dei latino-americani e il 36,4 degli asiatici americani. A livello nazionale, i neri americani costituiscono il 22,1% di tutti i decessi di razza conosciuta, pur essendo solo il 12,4% della popolazione (APM Research Lab, 2020).
Come per la precedente crisi finanziaria del 2007-2008, i riflessi e i costi economici del lockdown, col quale si è contrastata la diffusione del Covid-19, sono asimmetricamente distribuiti; lo stesso vale per i successivi sostegni e sussidi per la ripresa. Ma è vero pure che i ceti sociali più vulnerabili hanno pagato in misura sproporzionatamente maggiore anche quel “negazionismo dall’alto” che ha caratterizzato particolarmente gli Stati Uniti e il Brasile. In quest’ultimo paese, ma anche in diversi altri dell’America Latina, come Perù, Colombia e Messico, il virus ha colpito più pesantemente quella parte di popolazione che è costretta a vivere in baraccopoli e le comunità indigene. Frei Betto, sacerdote e teologo brasiliano, non ha esitato a definire quello in atto nel suo paese un vero e proprio genocidio, accusando il presidente Jair Bolsonaro (da lui soprannominato BolsaNero, poiché «continua a suonare la lira mentre il Brasile brucia»), di aver lasciato intenzionalmente diffondersi il virus per sbarazzarsi di poveri e di anziani: «Le ragioni dell’intenzionalità criminale del governo Bolsonaro sono evidenti: lasciare morire gli anziani, per risparmiare le risorse previdenziali; lasciare morire chi ha malattie preesistenti, per risparmiare risorse dal SUS, il sistema sanitario nazionale; lasciare morire i poveri, così da risparmiare risorse del programma Family Income e degli altri programmi sociali per i 52,5 milioni di brasiliani che vivono in povertà e per i 13,5 milioni che sono in estrema povertà» (Betto, 2020).
Si può o meno convenire con il giudizio del sacerdote domenicano, ma occorre considerare che persino in paesi europei, a un certo stadio di sviluppo della pandemia e di ingolfamento delle strutture ospedaliere, si è aperto un dibattito sulla necessità e liceità morale di selezionare quelli da salvare e quelli che non era possibile curare; in questo caso, non in base a cinici calcoli politici ma a valutazioni legate all’età e alle complessive condizioni di salute, in un’ottica da “medicina delle catastrofi”.
[…]
4. Il capitalismo dei disastri e il caso di Haiti
Capitalismo dei disastri, l’hanno definito alcuni autori e organizzazioni, documentandone alcune tragiche applicazioni, come nella gestione del post-terremoto di Haiti nel 2010. Una tragedia, presto accompagnata da una epidemia di colera e di nuovo aggravata dall’uragano Matthew nell’ottobre 2016, il cui bilancio iniziale fu di circa 220.000 vittime, poi salito a 316.000, di un milione e mezzo di persone rimaste senza casa, del 60% delle strutture sanitarie sull’isola distrutte, ma che vide parte consistente degli aiuti internazionali dirottati in operazioni di speculazione, corruzione e land grabbing, con aggravamento delle condizioni sociali e ambientali (Chérestal, 2015; Sensi, 2016).
Un decennio dopo il sisma, e dopo due anni di forti tensioni sociali con quasi 200 manifestanti uccisi, di proteste contro il carovita, l’aumento del costo della benzina e i brogli elettorali, di scandali che hanno coinvolto persino i Caschi Blu delle Nazioni Unite con casi di abusi e sfruttamento sessuale di adolescenti, nonostante gli sforzi per la ricostruzione e le attività umanitarie delle ONG, le ferite rimangono aperte e i problemi irrisolti o aggravati, con il sistema sanitario di nuovo al collasso, mentre cresce la crisi sociale, economica e politica (MSF, 2020).
L’importo di aiuti effettivamente stanziati dai donatori internazionali, circa 6,4 miliardi di dollari, è persino inferiore ai costi di permanenza, dal 2004 al 2014, della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, MINUSTAH), oltre 7,2 miliardi di dollari.
La spesa totale per Haiti da gennaio 2010, da parte dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (United States Agency for International Development, USAID), è stata di quasi 2,5 miliardi di dollari. Denaro che però non è andato a sostenere l’economia e le imprese locali, se non per un misero 2,6%, bensì a beneficio dei ricchi appaltatori nordamericani (Johnston, 2020).
Insomma, anche le catastrofi “naturali”, e soprattutto la loro successiva gestione, hanno contribuito a rendere più debole ed esposta una popolazione già considerata la più povera dell’emisfero occidentale: Haiti è al 169° posto su 189 paesi come indice di sviluppo umano, con sei milioni di abitanti, sugli undici totali, in condizioni di povertà, con un reddito di 2,42 dollari al giorno e 2 milioni e mezzo scesi sotto la soglia della povertà estrema, con 1,12 dollari al giorno. Un quadro che, con l’epidemia di Covid-19, non poteva che divenire ancor più drammatico (World Bank, 2020 a).
Più è economicamente e politicamente fragile un paese e più facile diventa, in caso di catastrofi, costringerlo a privatizzare le proprie magre risorse e i propri servizi pubblici. Per rimanere a quell’area geografica, è successo anche a Porto Rico nel 2017, dopo i disastrosi uragani che l’hanno colpito, o a New Orleans, dopo l’uragano Katrina del 2005. Ma è accaduto, in forme analoghe seppur con intensità e risultati differenziati, più o meno in tutti i paesi in via di sviluppo, costretti nei decenni scorsi a sottostare ai Piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale o, più di recente, ai Protocolli e Memorandum della cosiddetta “Troika” intervenuti nei confronti di paesi in difficoltà, come la Grecia. Esperienze e “salvataggi” che si sono tradotti, tra le altre cose, nel ridimensionamento della sanità pubblica a favore di quella privata e in altre pesanti “condizionalità”.
Una scelta strategica sciagurata e “ideologica” che ha aggravato le tragiche conseguenze che la pandemia del Covid-19 ha messo davanti agli occhi di tutti i cittadini, oltre a riattualizzare quel termine: condizionalità. Vale a dire prestiti subordinati all’adesione del paese che ne necessita a un programma di “riforme” e, soprattutto, di tagli alla spesa pubblica e ai sistemi di protezione sociale.
5. Lo shock pandemico prepara un futuro distopico
In questo senso e direzione, la pandemia del 2020 è stata una ghiotta occasione per le avidità di un mercato senza regole, che ha mobilitato gli appetiti e gli interessi delle multinazionali del digitale, oltre che del farmaceutico e della finanza speculativa. Lo ricorda Naomi Klein, che per prima ha analizzato e proposto la “dottrina dello shock” come chiave interpretativa delle forme assunte dal capitalismo contemporaneo, e che ora parla di «dottrina dello shock pandemico». Una logica che «considera le nostre settimane di isolamento fisico non una dolorosa necessità per salvare vite umane ma un laboratorio permanente e altamente redditizio di un futuro senza contatto fisico». Un futuro che, si dice, «sarà gestito dall’Intelligenza Artificiale, ma che in realtà sarà tenuto insieme da decine di milioni di lavoratori anonimi nascosti nei magazzini e nei data center, ammassati in uffici dove si moderano i contenuti o in fabbriche di elettronica, nelle miniere di litio, nei complessi industriali, nei mattatoi e nelle prigioni, esposti alle malattie e all’ipersfruttamento. È un futuro nel quale ogni nostra mossa, ogni nostra parola, ogni nostra relazione sarà rintracciabile, tracciabile, con una miniera di dati immagazzinati grazie a una collaborazione senza precedenti tra governi e giganti della tecnologia» (Klein, 2020).
Un futuro prossimo, delegato a tecnologie intelligenti, testate a livello di massa durante la pandemia, che a molti potrà apparire innocuo o, addirittura, desiderabile. Anche chi, in precedenza, manifestava obiezioni o esprimeva preoccupazioni dal punto di vista della privacy, dell’uso improprio e politicamente finalizzato dei Big Data da parte dei loro opachi proprietari e accumulatori, delle ulteriori diseguaglianze che la telemedicina o la didattica a distanza approfondiscono, della delega eccessiva agli apparati di polizia e del controllo, del potere enorme, connesso ai profitti incalcolabili (e alla loro scarsa o assente tassazione) dei giganti delle piattaforme digitali, si è trovato costretto dall’emergenza, imposta dalla pandemia e sapientemente utilizzata per isolare, ad ammutolire.
La paura, come spesso, è divenuta un cavallo di Troia delle politiche securitarie e di controllo, della militarizzazione dei territori e delle reti. Saperi tecnici e calcoli politici hanno trovato un’alleanza e una convergenza di interessi, che interseca il comparto militare e della sicurezza, in un’attualizzazione e riedizione di quel “complesso militar-industriale” di eisenhoweriana memoria, oggi integrato dal digitale.
In questo caso, lo scenario delineato e in itinere fruisce di un’accelerazione senza precedenti, oltre che senza resistenze. Un futuro distopico con caratteri di inarrestabilità. E anche questo è un suo punto di forza, solo in apparenza oggettivo. Un progetto che si basa sulla delega a società private – alle corporation del digitale – delle tradizionali funzioni degli apparati pubblici: dalla scuola alla sanità, dalla sicurezza alla difesa. Del resto, è almeno dalla ventennale guerra in Afghanistan e dalla, di poco successiva, invasione dell’Iraq che la privatizzazione della guerra e l’uso massiccio di contractor e società belliche private ha preso piede. Ora, anche sulla base di quella vincente e produttiva (per i profitti privati, naturalmente) esperienza, si vuole fare un salto e rendere irreversibile quel processo, attualizzandolo e implementandolo nelle sue diverse articolazioni.
Racconta Klein che il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo e l’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, nei giorni del Covid-19 hanno annunciato la grande «opportunità» che si presentava di immaginare e plasmare il futuro del dopo-pandemia. E non si può certo dire che Schmidt non se ne intenda o che non abbia i ruoli e gli strumenti per cogliere, e assieme imporre, quella «opportunità», giacché presiede il Defense Innovation Board, che consiglia il Dipartimento della Difesa nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in campo militare, così come è al vertice della potente Commissione per la sicurezza nazionale sull’Intelligenza Artificiale (National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI).
Ai tempi delle guerre in Iraq, di George Bush padre e figlio, dell’“uomo nell’ombra” Dick Cheney, di Donald Rumsfeld e anche di quel John Bolton consigliere della sicurezza nazionale per Donald Trump sino al settembre 2019, si era instaurato un oliato sistema di porte girevoli tra corporation del settore bellico e di quello petrolifero e governo politico, a tutto beneficio delle imprese e delle fortune private ma a discapito dei cittadini e delle popolazioni, oltre che del sistema democratico (Segio, 2019).
Ora, ci dice sempre Naomi Klein, negli ascoltati organismi che indirizzano le scelte strategiche e vagliano le opzioni militari della prima potenza mondiale, oltre a Schmidt – che possiede più di 5,3 miliardi di dollari in azioni della società madre di Google, Alphabet – sono presenti top manager e dirigenti di diversi colossi del digitale, tra cui Oracle, Amazon, Microsoft, Facebook. Schmidt «sta sostanzialmente “collaudando” Washington per conto della Silicon Valley», conclude l’attivista e scrittrice canadese.
Dalle porte girevoli tra imprese e politica si sta così arrivando alla completa subordinazione dei governi agli interessi di sviluppo, e di profitto, delle potenti multinazionali del digitale e dell’Intelligenza Artificiale, che intendono ottenere maggior mano libera e ancor più cospicui finanziamenti facendo leva sulla competizione con la Cina; tema su cui insiste molto Schmidt, il quale indica come condizioni per non perdere la sfida con il gigante asiatico una strategica e rafforzata partnership tra governo e industria e il raddoppio degli investimenti pubblici (Schmidt, 2020). Memore del fatto che la storia della Silicon Valley, e gli immensi profitti e poteri che lì hanno realizzato le diverse corporation tecnologiche via via proliferate, non esisterebbero senza gli investimenti pubblici iniziali, ricevuti in particolare dal Dipartimento della Difesa statunitense.
Indubbiamente, nel tempo della pandemia, e nonostante i ritardi nel comprendere e nel comunicare la gravità di quanto stava accadendo e che aveva avuto origine nel mercato di Wuhan, il “modello cinese” pare essersi affermato tra i decisori a livello globale come capace ed efficiente nella gestione delle emergenze, oltre che della forza lavoro. Come osserva ancora Klein: «Ora, con la pandemia e nella paura sul futuro che essa ha provocato, queste aziende hanno individuato un nuovo momento favorevole per spazzare via l’impegno democratico, e ottenere lo stesso tipo di potere che hanno i loro concorrenti cinesi, che possono permettersi il lusso di agire senza ostacoli quali diritti civili o dei lavoratori».
Dopo il lockdown globale, sempre più spesso e ancora più che prima, ai cittadini che chiedono democrazia i governi rispondono con leggi speciali (come a Hong Kong), arresti e violenze di polizia (da ultimo in Bielorussia o a Bangkok); a quelli che chiedono giustizia sociale e fine della corruzione (ad esempio, in Libano, in Venezuela o in Cile) distribuiscono manganellate e repressione, a quelli che lottano per i diritti umani (come in Iraq, nelle Filippine o in Colombia) riservano pallottole ed esecuzioni extragiudiziali.
Ma è durante il blocco e grazie ai poteri derivanti dall’emergenza che è divenuta forte ed evidente, anche nei paesi a democrazia consolidata, la tentazione di utilizzare a fini di controllo sociale le contingenti esigenze di controlli sanitari e di tracciamento dei contagiati. Uno stato di emergenza, ovvero la necessità di governare una situazione nuova, difficile e temporanea, facilmente può slittare ed essere trasformato in uno Stato di eccezione, vale a dire in una sospensione delle regole giuridiche democratiche, in un accentramento e verticalizzazione dei poteri, in un rigido disciplinamento sociale, in una vulnerazione di diritti e libertà. Tra i tanti esempi possibili, basti ricordare ciò che è seguito all’11 settembre 2001: il waterboarding e la legittimazione della tortura, i voli della CIA e le extraordinary rendition, Guantánamo e Abu Ghraib, quei vulnus dello Stato di diritto e della coscienza democratica che a distanza di vent’anni non sono rimarginati e ricuciti. E che, anzi, hanno prodotto e riprodotto tossine e assuefazioni ancora pericolosamente in circolo.
[…]
9. Superpoteri per “fare del bene”, la pandemia come opportunità
«Insomma, oggi la filosofia della Apple e di Google può essere sintetizzata così: mai sprecare una crisi grave». E in quella pandemica, naturalmente, tutti i giganti del digitale ci si sono prontamente buttati, anche se alcuni, come Google o Apple, in campo sanitario lavoravano da tempo. Nell’agosto 2020 vi si è aggiunta Amazon, che ha lanciato la sua prima fitness band, Halo, specializzata nel monitoraggio della salute. Oltre che nel contact tracing, la tecnologia per il tracciamento delle infezioni da Covid-19 mediante lo smartphone, una delle aziende della holding di Google, Alphabet, attraverso Verily, ha potuto subito organizzare lo screening con il prelievo dei tamponi direttamente in automobile, profittando del servizio offerto per raccogliere una quantità di dati degli utenti. Come ormai abbiamo imparato, per le piattaforme digitali i dati sono moneta sonante. Fatto che non evita alla multinazionale di colorare di sentimenti filantropici le proprie attività, ripetendo sharing is caring, la condivisione è prendersi cura.
Lo stesso dice di sé Fabebook: data for good, i dati servono a fare del bene. L’azienda di Mark Zuckerberg ha visto nella pandemia l’opportunità di fare un salto da social network a rete di ricerca, in collaborazione con università, istituzioni mediche e fondazioni per sviluppare l’Intelligenza Artificiale nei servizi di cura e nei modelli predittivi in campo sanitario. La massiccia raccolta di dati, profili e preferenze che poco tempo fa, nel 2018, aveva dato luogo allo scandalo Facebook-Cambridge Analytica, con l’uso improprio e illegittimo di dati a uso politico ed elettorale, ora, solo due anni dopo, grazie alla pandemia assume un’altra sembianza e valenza. Come ha detto Zuckerberg: «Già in passato il mondo ha dovuto affrontare le pandemie, ma oggi abbiamo un nuovo superpotere: sappiamo raccogliere e scambiare dati per fare del bene» (Nosthoff, Maschewski, 2020).
Il capitalismo della sorveglianza al tempo del Covid-19 si presenta dunque come speranza per l’umanità, facendo leva sulla paura, ma anche sulla debolezza della politica, che ha da tempo aperto larghe praterie all’iniziativa privata for profit in campi che pertengono ai diritti fondamentali dei cittadini, ma che sono invece stati posti sul mercato. Fatto sta che, nei mesi dell’emergenza sanitaria, le corporation tecnologiche hanno visto impennarsi il proprio valore in Borsa. Al 19 giugno 2020 Amazon era valutata 1.317,3 miliardi di dollari, il 43,8% in più rispetto all’inizio dell’anno; Microsoft 1.473 miliardi (+22,4%); Apple 1.523,9 (+16,8%); Facebook 671 miliardi (+14,6%); Alphabet 991,1 miliardi (+7,4%); PayPal 192,4 miliardi (+51,5%); Netflix 196,9 (+38,9%); Zoom 66,8 miliardi (+255,1%). Una tendenza, peraltro, in rapidissima evoluzione: già ad agosto 2020 Apple ha superato una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari, un primato a Wall Street. Fondata nel 1976, aveva raggiunto una capitalizzazione di 1.000 miliardi nel 2018; in soli due anni ha quindi raddoppiato il suo valore, il che dà l’idea delle dinamiche in corso e di quanto la crisi finanziaria globale del 2008 abbia ulteriormente determinato dinamiche piramidali, di concentrazione di ricchezza e di potere. Subito dopo il colosso informatico diretto da Tim Cook, ora si colloca Saudi Aramco, compagnia petrolifera saudita, con una capitalizzazione di 1.800 miliardi.
[…]
17. Senza multilateralismo si avvicina la mezzanotte del mondo
Per quanto riguarda il bilancio di questi anni, va constatato che la politica internazionale portata avanti da Trump non ha certo giovato alla stabilità mondiale. Anzi. Il suo mandato, cominciato nel novembre 2016, ha visto susseguirsi scelte di rottura del multilateralismo: con il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima, da quello sul nucleare con l’Iran, dal Trattato sui missili nucleari a medio raggio (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dall’Agenzia culturale delle Nazioni Unite; ha poi tagliato i finanziamenti per il fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e per l’Agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi e, infine, durante la pandemia, ha annunciato il ritiro, che diventerà operativo il 6 luglio 2021, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), a cui peraltro deve 200 milioni di dollari di contributi non versati.
Nel frattempo, Trump aveva innescato le guerre commerciali contro la Cina, ma anche contro l’Europa, sempre meno considerata come importante alleato.
Anche la politica seguita in America Latina dalla sua Amministrazione ha mostrato vistosi errori, come ad esempio il sostegno a oltranza a un personaggio politico decisamente poco credibile come il venezuelano Juan Guaidó e alle sue operazioni golpiste o come la nuova rottura delle relazioni con Cuba, dopo il positivo processo di aperture portato avanti da Obama. Lo stesso vale per il Medio Oriente, dove ha continuato a versare benzina sul fuoco, prima con lo spostamento dell’Ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, poi con il suo “Deal of the Century”, che ha provocato anche una richiesta alla Corte Penale Internazionale di indagare sui possibili crimini di guerra contro il popolo palestinese da quel Piano provocati. Da ultimo, con l’accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, patrocinato dagli Stati Uniti e peraltro approvato anche da Joe Biden, che ancora una volta umilia e sottrae prospettive al popolo palestinese, poiché fa crollare «l’insieme di argomentazioni usate per difendere la necessità di una soluzione. È difficile definire “insostenibile” l’occupazione che va avanti da 53 anni ora che Netanyahu ha dimostrato non solo che è sostenibile, ma che Israele può continuarla mentre migliora i rapporti con il mondo arabo alla luce del sole» (Pfeffer, 2020).
Nella stessa strategia di mutamento del quadro e delle alleanze in quell’area si inserisce l’annuncio, di poco successivo, fatto da Trump, secondo cui anche Serbia e Kosovo sposteranno le proprie ambasciate da Tel Aviv a Gerusalemme, seguendo la strada di rottura (anche del diritto internazionale) da lui aperta. Una strada che, se modifica in profondità gli scenari geopolitici – sacrificando le storiche e legittime rivendicazioni palestinesi –, così facendo introduce nuove tensioni e disequilibri; oltre a sancire un’ennesima volta la perseguita irrilevanza delle Nazioni Uniti, all’insegna dell’unilateralismo e del diritto del più forte.
A tale strategia è anche da ascrivere l’offensiva preventiva posta in essere dall’Amministrazione Trump contro la Corte Penale Internazionale – salutata e condivisa con entusiasmo da Benjamin Netanyahu. Il segretario di Stato Michael Pompeo, il 2 settembre 2020, annunciando sanzioni economiche contro suoi funzionari, ha definito la Corte internazionale «un’istituzione completamente distrutta e corrotta». Gli Stati Uniti non hanno mai ratificato lo Statuto di Roma che ha creato il tribunale internazionale, e Pompeo assicura che «non tollereremo i suoi tentativi illegittimi di sottoporre gli americani alla sua giurisdizione» (Pompeo, 2020; Boeglin, 2020).
La rivendicazione è netta, e sfrontatamente esplicita: gli Stati Uniti non sono sottoponibili al diritto internazionale. Chi ci provasse, diventerebbe un nemico da contrastare e combattere.
È un passaggio ulteriore di quel processo che ha visto l’esercizio della forza e la politica dell’imposizione del dato di fatto progressivamente affermarsi, in particolare in Medio Oriente e nel Mediterraneo, nella manifesta impotenza delle Nazioni Unite e dell’Europa, per responsabilità degli Stati Uniti, ma non solo.
Vero è che l’attivismo destabilizzatore di Trump ha imposto un nuovo e pericoloso disordine mondiale, in cui in particolare l’Unione Europea rischia di diventare ininfluente.
Del resto, è pure, se non soprattutto, in base alle scelte di Trump, in particolare sul clima e sulle armi nucleari, che gli scienziati atomici nel gennaio 2020 hanno spostato in avanti di 20 secondi le lancette del Doomsday Clock, il simbolico orologio creato dopo Hiroshima e Nagasaki, che da 73 anni indica la distanza temporale dalla mezzanotte del mondo, ovvero dall’apocalisse. Ora mancano solo 100 secondi, un livello di pericolo mai raggiunto sinora, neppure nei momenti più tesi del confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica del secolo scorso. Gli scienziati hanno motivato la decisione in questo modo: «Quest’anno, spostiamo l’orologio di 20 secondi più vicino alla mezzanotte non solo perché le tendenze nelle nostre principali aree di preoccupazione – armi nucleari e cambiamento climatico – non sono riuscite a migliorare in modo significativo negli ultimi due anni. Spostiamo l’orologio verso mezzanotte perché i mezzi con cui i leader politici avevano precedentemente gestito questi potenziali pericoli di fine civiltà vengono smantellati o indeboliti, senza uno sforzo realistico per sostituirli con regimi di gestione nuovi o migliori. In effetti, l’infrastruttura politica internazionale per il controllo del rischio esistenziale si sta degradando, lasciando il mondo in una situazione di minaccia alta e crescente. I leader globali non stanno rispondendo in modo appropriato per ridurre questo livello di minaccia e contrastare lo svuotamento delle istituzioni politiche internazionali, dei negoziati e degli accordi che mirano a contenerlo» (Bulletin of the Atomic Scientists, 2020).
È l’ennesimo grido di allarme, che si aggiunge a quelli delle migliaia di scienziati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), i cui studi documentano, al di là di ogni possibile dubbio, i pericoli legati al riscaldamento climatico e i tempi necessari per le contromisure, già ampiamente disattesi grazie al negazionismo dei leader di paesi determinanti come gli Stati Uniti e il Brasile, il quale, anzi, con Bolsonaro e la lobby della bancada ruralista, ha ancor più lasciato mano libera alle deforestazioni in Amazzonia e ai distruttivi interessi dell’agrobusiness e dell’estrattivismo, col corredo di uccisioni e violazioni sistematiche dei diritti delle comunità indigene, come riepiloghiamo qui nel contributo dedicato all’ambiente.
Del resto, dicono gli scienziati atomici, «negli Stati Uniti c’è un attivo antagonismo politico verso la scienza e un crescente senso di disprezzo approvato dal governo per l’opinione degli esperti». E lo si è visto di nuovo durante la pandemia del Covid-19, col risultato di decine di migliaia di morti, in parte evitabili: al 1° settembre 2020, i primi due paesi al mondo per contagi e decessi erano Stati Uniti (con, rispettivamente, 6.031.013 e 183.598) e Brasile (3.908.272 contagiati e 121.381 morti), in un quadro globale di 25.488.637 contagiati e 850.605 decessi (Johns Hopkins University, 2020).
Oltre allo sciagurato negazionismo sul clima e alla, altrettanto sciagurata, sottovalutazione dei pericoli connessi al Covid-19 da parte di Trump e Bolsonaro, in quest’anno ha pesato negativamente l’impossibilità fisica alla mobilitazione dei movimenti e dei milioni di persone che in tutto il mondo si erano in precedenza efficacemente attivati per sensibilizzare i cittadini e per sollecitare i governi nel prendere adeguata coscienza e attuare efficaci misure di contenimento del riscaldamento globale. Così pure, pesa il rinvio della ventiseiesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Conference of the Parties, COP26), inizialmente prevista a Glasgow nel novembre 2020, ma slittata di un anno a causa dell’epidemia.
Quale piccola consolazione, va registrato che il blocco mondiale indotto dal coronavirus ha causato una contrazione del 10% dell’Impronta Ecologica, secondo le rilevazioni di Global Footprint Network. Un sollievo assai magro, dato che, in ogni modo, alla data del 22 agosto, aveva richiesto alla natura una quantità di risorse pari a quella che la Terra produce in un intero anno.
Gli squilibri e il sovrasfruttamento del pianeta, insomma, permangono gravi e minacciosi sul futuro. Come sottolinea il network ambientalista, non è ai disastri che ci si può affidare ma a strategie precise e a cambiamenti sostanziali e duraturi riguardo la decarbonizzazione, i sistemi alimentari, le politiche riguardo la mobilità, e così via. Chiamati in causa sono tanto le aziende e i governi quanto le comunità e gli individui.
Il superamento globale è iniziato nei primi anni Settanta del secolo scorso; il debito ecologico cumulativo cui siamo giunti è equivalente a 18 anni terrestri. Questa enorme distanza ci dice l’entità del problema e le drammatiche urgenze per farvi finalmente fronte (Global Footprint Network, 2020).
Vi è tuttavia chi sostiene, con qualche ragione e riscontro, che responsabilizzare – o colpevolizzare – i singoli in quanto consumatori sia una precisa strategia per occultare che la vera questione è l’azione politica e le scelte produttive delle aziende inquinanti, che hanno scoperto l’utilità anche economica del greenwashing e che investono risorse in campagne di comunicazione per convincere i cittadini che la responsabilità del cambiamento o meno è loro, così da poter continuare indisturbate a fare profitti con attività ambientalmente insostenibili. Come, ad esempio, la ExxonMobil, una delle più grandi aziende petrolifere del mondo, «al centro di vari casi giudiziari per aver ingannato i cittadini nel tentativo di ostacolare le politiche contro il cambiamento climatico». O come la BP, altro colosso petrolifero: una sua campagna del 2005 ha contribuito ad affermare il concetto dell’impronta ecologica individuale, proponendo un sistema col quale ogni famiglia poteva misurare le proprie emissioni di anidride carbonica (Tielbeke, 2020).
Un modo per distogliere l’attenzione dal problema reale e dalle principali responsabilità, dato che sole venti società energetiche, di cui dodici di proprietà statale, sono responsabili del 35% di tutte le emissioni di gas serra: «Nuovi dati di ricercatori di fama mondiale rivelano come questa coorte di imprese statali e multinazionali stia guidando l’emergenza climatica che minaccia il futuro dell’umanità, e spiega in dettaglio come hanno continuato a espandere le loro operazioni nonostante siano consapevoli dell’impatto devastante del settore sul pianeta». Dati così commentati da Michael Mann, uno dei principali scienziati del clima al mondo: «La grande tragedia della crisi climatica è che sette miliardi e mezzo di persone devono pagarne il prezzo – sotto forma di un pianeta degradato – affinché un paio di dozzine di interessi inquinanti possano continuare a realizzare profitti record» (Taylor, Watts, 2019).
Una consapevolezza e una devastazione che dicono di un crimine ecologico reiterato e impunito; reiterato perché impunito. Individuare i crimini, chiamarli col loro nome, indicarne i responsabili, denunciare la loro azione, smascherare le loro interessate bugie e le capziose strategie difensive è l’unico modo per interromperli. Ciò vale anche per i crimini di sistema.
Non sono state le campagne pubblicitarie e le strategie di comunicazione di qualche azienda, ma le proteste dei movimenti e la mobilitazione di milioni di studenti, di giovani e di meno giovani, gli interventi Greta Thunberg davanti ai decisori politici mondiali, le efficaci azioni comunicative di Extinction Rebellion e combattivi parlamentari come Alexandria Ocasio-Cortez negli Stati Uniti, gli studi e le ricerche degli scienziati e di organismi internazionali indipendenti ad aver imposto ad agende politiche e a governi la Green Deal. Che questa trovi, dove è già stata decisa, come in Europa, le necessarie risorse e implementazioni coerenti nei tempi e nei modi dovuti non è per nulla scontato. Per quanto utili, dovuti e necessari, non saranno gli stili di vita e di consumo individuale a garantirlo, né tanto meno le finte conversioni del mercato, ma la rinnovata e costante pressione e mobilitazione politica di quegli stessi soggetti.
18. Covid-19 e diritti umani
Oltre che sull’ambiente e sulle politiche riguardo il clima, la gestione della pandemia a livello globale ha riverberato in modo negativo sui diritti umani.
Se è vero che molti paesi, seguendo le raccomandazioni degli organismi sanitari e delle Nazioni Unite, hanno rilasciato un certo numero di detenuti al fine di limitare il contagio e stanti le condizioni di sovraffollamento quasi generalizzate, è anche vero che molti hanno escluso dalle misure i dissidenti politici nonché gli attivisti dei diritti umani. Dalla Turchia all’Iran, all’Egitto, al Bahrein, a Hong Kong, alla Cina, alle Filippine, alla Colombia, El Salvador, Messico, ma anche alla Spagna riguardo gli autonomisti catalani. Contemporaneamente, il Covid-19 è divenuto ulteriore pretesto per il condizionamento dell’informazione e per la repressione di giornalisti in numerosi paesi, tra cui: Cina, El Salvador, Iraq, Turchia, Serbia, Egitto, Iran, Bielorussia e Vietnam (Joseph, O’Donovan, 2020).
Leggi di emergenza, maggiori poteri alle polizie, sorveglianza pervasiva del territorio e dei cittadini hanno caratterizzato le politiche di contenimento della pandemia pressoché ovunque. In diversi paesi sono state però utilizzate quale pretesto per controllare e reprimere il dissenso interno, limitare le libertà fondamentali e per militarizzare la società, suscitando l’attenzione e l’allarme dell’Ufficio delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario per i diritti umani, i cui esperti hanno fatto appello ai governi affinché le misure di emergenza prese non venissero utilizzate per negare o compromettere diritti umani. Lo stesso Alto Commissario, Michelle Bachelet, è intervenuto per richiamare alla necessità che tutte le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, i blocchi e le quarantene, rispettassero comunque gli standard sui diritti umani e fossero proporzionate al rischio valutato (OHCHR, 2020 a; 2020 b).
Sono stati numerosi i paesi che, in quel periodo, hanno introdotto norme e misure di limitazione di particolari sfere o di complessive libertà dei cittadini: 90 paesi hanno adottato leggi di emergenza, 42 misure che limitano la libertà di espressione, 122 che impediscono quella di assemblea o riunione, 41 con effetti sulla privacy (ICNL, 2020).
In Arabia Saudita, nei mesi della pandemia, si sono perse le tracce dei prigionieri di coscienza, poiché sono state interrotte le comunicazioni con i famigliari, come è successo all’attivista per i diritti delle donne, protagonista della campagna per il diritto alla guida, Loujain Al Hathloul, o al religioso Salman al-Odah o alla principessa Basmah bint Saud. «Se trattano i reali, la loro stessa famiglia, in questo modo, senza giustizia, si può immaginare cosa sta succedendo con le altre persone», ha detto Eva Kaili, membro del Parlamento Europeo (Allinson, 2020).
Ma sono molti i paesi che le leggi di emergenza le avevano e le usavano senza remore anche prima della pandemia. Leggi per limitare diritti, per discriminare minoranze, per reprimere i dissensi, per consentire mano libera alle polizie. Paesi dove resistere spesso vuol dire essere costretti a forme di lotta e di denuncia estreme, come quella dello sciopero della fame; vuol dire perdere la vita come in Turchia, il cui pericoloso interventismo militare e geopolitico all’esterno, nel Medio Oriente, nel mar Egeo e nel Mediterraneo, si è accompagnato con una recrudescenza della violazione dei diritti umani all’interno.
Avvocati, giornalisti, avversari politici, minoranze etniche, addirittura parlamentari e sindaci sono finiti in gran numero nella macchina disumana della repressione e del carcere. Diversi sono stati lasciare morire in cella, dopo prolungati scioperi della fame, senza che alla solidarietà internazionale delle associazioni e della società civile sapesse unirsi quella delle istituzioni sovranazionali.
Anche in Cile, per i rappresentanti del popolo mapuche nell’estate del 2020 non vi è stata altra scelta che quella di mettere in gioco il proprio corpo e la propria vita con prolungati scioperi della fame e della sete, senza che il governo provasse a prendere atto delle ragioni e a restituire diritti.
L’epidemia è stata pretesto e occasione per intensificare la militarizzazione e la repressione contro comunità e movimenti in tutta l’America Latina, indipendentemente dal fatto che i governi siano di destra dichiarata o considerati progressisti. In Argentina, dal 20 marzo al 6 agosto, sono stati contati 92 morti per mano di membri di forze statali, di cui 45 avvenute all’interno di carceri o caserme. In Brasile, nonostante la minor presenza di gente per le strade, le morti causate dalla polizia durante la pandemia sarebbero aumentate del 26%. Tanto che, a maggio 2020, il pattugliamento militare nelle favelas della capitale è stato sospeso per decisione della Corte suprema federale, dopo che era avvenuto un massacro di 12 persone. In Colombia le uccisioni a opera di gruppi paramilitari sono pressoché quotidiane. Anche in Messico e in Cile nel periodo della pandemia sono avvenute aggressioni alle comunità locali da parte di paramilitari, che agiscono spesso in combutta con narcotrafficanti e forze statali (Zibechi, 2020).
Qualche buona notizia sul fronte dei diritti umani, tuttavia, è arrivata anche in questo periodo. Come la decisione del governo di transizione del Sudan di rimuovere le politiche discriminatorie verso donne e minoranze in vigore con il precedente governo di Omar al-Bashir, costretto ad abbandonare il potere nel 2019, poi condannato per corruzione e già ricercato dalla Corte Penale Internazionale, che lo accusa di crimini nel conflitto in Darfur del 2003, che aveva portato alla morte di 300.000 persone. Le nuove leggi ora introdotte vietano le mutilazioni genitali femminili, aboliscono l’obbligo per le donne di ottenere i permessi di viaggio e depenalizzano l’apostasia.
*****
Dal 18° Rapporto sui diritti globali – Stato dell’impunità nel mondo 2020, “Il virus contro i diritti”, a cura di Associazione Società INformazione.
Scarica qui l’indice integrale della introduzione e dell’intero volume in pdf.
Related Articles
Il G7 avverte la Russia «Annettere la Crimea violerebbe la Carta Onu»
![]()
Il premier ucraino: non ci arrendiamo
Codice Minniti. Il deserto sociale e culturale dove trionfa l’inumano
![]()
È IL MINISTRO Minniti, e non le Ong, ad aver fatto accordi con i veri scafisti
Nessuna regione al Front National Le Pen: “Il regime è in agonia” Sarkozy vince, ma il partito si divide
![]()
I ballottaggi. Al centrodestra maggioranza in sette Consigli anche grazie al passo indietro strategico fatto dai socialisti. Il Ps piazza cinque candidati: un successo per Hollande oltre le aspettative





