Vittorio Agnoletto: «La protezione dei profitti aziendali ha influenzato le decisioni»
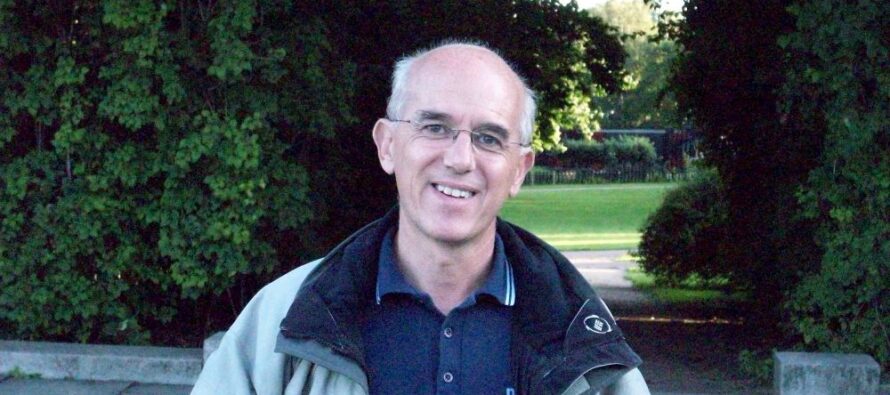
![]()
Vittorio Agnoletto è laureato in medicina con specializzazione in medicina del lavoro, attività che svolge da oltre trent’anni, con un rigore nella tutela della salute di lavoratori e cittadini che spesso gli è costato attacchi e rappresaglie. Alla competenza scientifica e professionale assomma una passione civile, sociale e politica d’altri tempi, maturata nella straordinaria stagione che seguì al ’68 e tuttora mantenuta con coerenza. Attivista altermondialista, è stato portavoce del Genoa Social Forum, in occasione del G8 del 2001 e membro del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, è stato anche Parlamentare europeo. Ha anche lunga esperienza di malattie infettive, avendo fondato e presieduto la Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS e fatto parte della Commissione Nazionale AIDS, attualmente è membro della direzione di Medicina Democratica.
In queste settimane di emergenza Coronavirus, si sta adoperando senza sosta in vario modo, anche attraverso i programmi radiofonici di Radio Popolare e numerose dirette video, per fornire risposte alle tante domande e preoccupazioni che arrivano dai cittadini.
Agnoletto conclude questa lunga e articolata intervista ricordando che la Spagna ha immediatamente e positivamente deciso che le strutture, le apparecchiature, le cliniche e gli ospedali privati possano essere requisiti se ve ne è necessità per la sanità pubblica. Una misura chiara che l’Italia non ha avuto il coraggio di prendere, come del resto non ha saputo resistere alle ragioni e pressioni degli imprenditori e del profitto, consentendo a tutt’oggi la continuazione di attività produttive non necessarie, determinando in questo modo l’estensione del contagio e un pesante rischio e danno per la salute e la vita di tanti lavoratori e cittadini. Un gravissimo errore, che gli altri paesi dove l’epidemia sta crescendo non devono assolutamente seguire e ripetere.
L’evoluzione e le cifre dell’epidemia in Italia sembrano indicare errori e ritardi nell’affrontamento e nelle risposte. Se è così, quali sono questi errori? Si sarebbero potuti evitare, e come?
Tra la comparsa del virus in Cina, l’individuazione delle sue vie di trasmissione e la sua apparizione in Occidente e in Italia è trascorso parecchio tempo, almeno un mese, un mese e mezzo. Questo periodo viene definito dall’OMS come una “finestra d’opportunità”, cioè un tempo a disposizione dei governi per attivare gli strumenti di prevenzione e di informazione, per organizzarsi a contrastare l’arrivo del virus, l’epidemia. Il fatto che il Coronavirus potesse giungere in Occidente e in Italia era altamente probabile, perché nell’epoca della globalizzazione è difficile immaginare che un’infezione di questo tipo possa rimanere all’interno di un solo paese.
Purtroppo, quel mese e mezzo non è stato utilizzato come si doveva. In particolare, ci si è concentrati sulla questione dei confini, dei viaggi aerei; anche giustamente, ma con degli errori, come il blocco dei voli diretti dalla Cina ma non di quelli che triangolavano, passando da un altro hub. Soprattutto, non si sono attivate una serie di misure importanti e ci sono stati diversi errori.
Primo. A livello nazionale si è fornito come numero telefonico di riferimento per informazioni o per segnalare casi sospetti il 112, un numero già esistente per le emergenze che non avrebbe dovuto essere bloccato da migliaia di telefonate per il Coronavirus, escludendo così altri tipi di urgenze. Si sarebbe dovuto invece attivare un numero verde ad hoc, con personale preparato. Quando sono stati infine individuati i numeri regionali, non è stato messo a disposizione da subito un numero adeguato di operatori.
Secondo. In Italia abbiamo una cosa che il mondo ci invidia: una rete diffusa di medici di medicina generale. Ogni cittadino italiano, ogni immigrato residente sul territorio, ogni minore immigrato anche irregolare possono e devono essere iscritti con un medico di medicina generale. Tutte le persone si rivolgono prima di tutto al loro medico. Quindi la cosa fondamentale da fare sarebbe stata di preparare i medici di base, dare loro le protezioni adeguate, perché quel personale sanitario costituisce la prima barriera alla diffusione del virus. Non è stato fatto. Il virus compare nella cittadina di Codogno, in provincia di Lodi, il 21 febbraio e la prima possibilità di andare a ritirare le mascherine, i camici e i guanti monouso viene data ai medici di medicina generale solo il 4 marzo, dalle 16 alle 20; già verso le 18 i camici erano esauriti e le mascherine pochissime. Si sono lasciati andare allo sbaraglio i medici di medicina generale e non è perciò un caso che molti si siano infettati. Ciò è stato un disastro, perché proprio quando il virus si è diffuso questi medici erano impossibilitati a esercitare.
Terzo. Non sono state date le indicazioni corrette neanche ai cittadini sul cosa fare e dove andare. Non si doveva aspettare l’arrivo del virus in Italia: già si conoscevano le vie di trasmissione e si sapeva che anche in Cina si erano infettati per primi gli operatori sanitari. Quindi l’indicazione avrebbe dovuta essere: se ritenete di esservi contagiati, non recatevi immediatamente al pronto soccorso o dal medico di base, ma chiamate il numero verde regionale o il vostro medico, evitando in questo modo quelle situazioni che poi si sono verificate a Codogno, con il contagio di medici e personale del pronto soccorso.
Le informazioni non sono state date né alla popolazione né ai medici, quando, vista l’esperienza cinese, avrebbero potuto e dovuto essere fornite prima dell’arrivo del virus. Le campagne di allertamento dovevano e potevano essere fatte prima. Questo tipo di errori, come peraltro dichiarato in un comunicato degli Ordini dei medici e degli infermieri, ha fatto sì che si è rischiato – ma in più casi è effettivamente avvenuto – di trasformare il personale che poteva curare in potenziali diffusori del virus. Così come sono state attivate in ritardo le altre misure. La dichiarazione di “zona rossa” in dieci paesi del lodigiano è stata giusta, mentre si è colpevolmente rallentata molto l’assunzione di misure in tutta la Lombardia. Non dimentichiamo che in Cina hanno isolato un’intera regione che ha una popolazione quasi pari a quella italiana, 58 milioni.
Quando si sono prese in Italia quelle misure si è fatto un errore del quale oggi discute tutta l’Europa. Sono state chiuse le scuole, ma non i luoghi di lavoro. Ciò ha comportato che molti bambini venissero affidati ai nonni. Eppure, dalla Cina già arrivavano le notizie secondo cui i bambini si infettavano molto difficilmente, ma qualora lo fossero trasmettevano l’influenza, pur in modo asintomatico o lieve. I bambini, venendo affidati ai nonni, in quel caso potevano contagiare la popolazione più fragile, gli anziani.
In Norvegia, invece, la chiusura delle scuole è stata concomitante con quella dei luoghi di lavoro. Per i lavoratori costretti a continuare ad andare a lavorare, perché svolgevano funzioni indispensabili, si sono lasciate aperte le scuole per i loro figli dove, anziché magari 300 ragazzi ce n’erano 15, evitando in quel modo che fossero affidati ai nonni.
Il tasso di letalità del Covid-19 in Italia supera quello di tutti gli altri paesi, Cina compresa. È così o è un’apparenza statistica? Se è così, quali sono le cause o le concause?
Non c’è una risposta certa, ma si possono fare alcune riflessioni. Teniamo presente che, dopo la fase iniziale, l’Italia ha fatto solo tamponi mirati, nel senso che li sta prevedendo unicamente per persone con temperatura corporea superiore a 37.5 e con una sintomatologia respiratoria. Il numero dei morti è relativo alle persone cui è stato fatto il tampone, dunque a persone che, in quanto in fase sintomatica, è più probabile possano arrivare al decesso; perciò la percentuale calcolata tra i decessi e le persone cui è stato fatto il tampone risulta alta. Ma noi sappiamo, almeno così ci dice l’OMS, che alla fase sintomatica giunge circa il 20% di coloro che sono stati infettati. In teoria, le persone che hanno il virus dovrebbero essere circa cinque volte tante quelle sottoposte al tampone. Attenzione: questi sono solo numeri di orientamento, cifre di massima.
In Italia c’è un’attesa di vita ancora molto alta, pur se negli ultimi due anni è diminuita; è tra i paesi al mondo in cui le persone vivono più a lungo, grazie all’approccio universale del sistema sanitario. Ma c’è un dato di cui nessuno parla: negli ultimi 7-8 anni in Italia c’è stato un forte peggioramento di un indice utilizzato dall’OCSE per valutare lo stato di salute della popolazione: è fortemente diminuito il numero di giornate libere da patologie della popolazione ultrasessantacinquenne.
C’è attesa di vita alta, ma la situazione si sta aggravando. Ci sono milioni di persone che non riescono ad accedere alle cure per i loro costi, c’è difficoltà nel fare alcune terapie – soprattutto fisioterapia e odontoiatria –, quindi peggiora la qualità di vita degli anziani, quindi aumentano le malattie per gli over 65 e ciò li rende più vulnerabili di fronte al virus. C’è poi un altro aspetto che riguarda in modo particolare l’Italia: l’alta percentuale di persone anziane, che possono più facilmente essere immunodepresse, avere un organismo maggiormente compromesso da precedenti patologie.
C’è relazione tra la particolare virulenza del Coronavirus in determinate zone e aree geografiche (ad esempio la Lombardia) e le complessive condizioni ambientali (inquinamento, polveri sottili, sistema della mobilità, ecc.)?
Non è possibile fare al riguardo affermazioni nette. È uscita qualche ricerca in proposito su riviste scientifiche, ma con ipotesi che devono essere ancora confermate. Una delle ipotesi è che aver vissuto per decenni in una zona fortemente inquinata come la Pianura padana possa aver favorito la fragilità dell’organismo, specie dei più anziani di fronte al virus. Su questo non c’è però al momento nessuna conferma. Si può tuttavia fare un ragionamento. L’apparato respiratorio è quello che viene più attaccato dal virus, quindi banalmente se il nostro apparato è stato posto sotto stress per decenni, è chiaro che sarà più debilitato. La Cina ha individuato alcuni determinanti sociali che favoriscono la diffusione del virus e soprattutto l’evoluzione verso le fasi sintomatiche. È interessante notare come fra questi ci sia una storia prolungata di esposizione al fumo di sigarette.
Nonostante i decreti del governo italiano, le norme sul distanziamento sociale, le zone rosse, in quelle aree l’estensione del contagio non sembra arrestarsi. C’è effettivamente un problema di scarso rispetto delle disposizioni? Quanto incide? Quanto pesa, anche o invece, la scelta di mantenere aperte le attività produttive non essenziali? Si può dire che, pure in questa situazione di emergenza, le ragioni non tanto dell’economia quanto delle imprese hanno sempre e comunque la prevalenza sull’interesse pubblico? Se sì, quali le ragioni, le cause, le responsabilità?
La decisione di stabilire una zona rossa in dieci paesi del lodigiano penso abbia funzionato. Si è arrivati a un’inversione della curva del contagio. Il problema è diverso allorché si sono estese le misure a livello dell’intera Lombardia e nazionale. Sulla difficoltà del rispetto delle disposizioni ci sono vari motivi, anche culturali. L’Italia non è la Cina. C’è una visione molto più individualistica della vita, c’è sicuramente un minor senso della collettività e dei doveri, al di là ovviamente delle differenze delle leggi e punizioni per chi non rispetta le disposizioni. Poi c’è un altro aspetto. Il fatto di mantenere aperte le attività produttive ha costituito sicuramente un problema, per diversi motivi. Primo, perché ha reso necessario mantenere una certa mobilità e quindi i mezzi pubblici di trasporto erano tutt’altro che vuoti. Secondo, perché sui luoghi di lavoro non è sempre possibile rispettare le norme e le distanze di sicurezza. Terzo, non ci sono le mascherine e i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, figuriamoci se ci sono nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. Quarto, la cosa fondamentale: in questi ultimi decenni la medicina del lavoro è stata fortemente ridotta, quasi azzerata all’interno della struttura pubblica. I medici del lavoro non sono più in carico alle ASL, neanche in modo convenzionato, ma sono liberi professionisti che dipendono dal datore di lavoro. Alle ASL è rimasto unicamente il ruolo ispettivo e di sorveglianza, ma hanno personale scarsissimo e quindi riescono a svolgere questa funzione assai poco e in casi isolati. È scomparsa una cultura della medicina del lavoro rispetto all’osservanza delle misure di precauzione universale previste dall’OMS. Per fare un solo esempio, basti pensare che l’ASL di Milano ha inviato la prima disposizione ai medici del lavoro solo tre settimane dopo l’esplodere del focolaio di Codogno, pur già disponendo dell’elenco con tutti i loro nomi e recapiti.
Non c’è dubbio che nelle decisioni assunte dai governi centrali e locali un forte peso lo hanno avuto le ragioni del profitto. Non è un caso che la Confindustria lombarda, alla viglia delle decisioni del governo, è intervenuta per sostenere che le attività produttive non dovevano essere chiuse.
Quanto pesa sulla drammatica situazione italiana la scelta ormai decennale, operata da governi diversi, di disinvestire dalla sanità pubblica per favorire quella privata e convenzionata? Ci può dare delle cifre? I provvedimenti recenti del governo non finiscono per portare altre risorse economiche proprio a quel privato? È immaginabile che si esca da questa emergenza con una inversione di rotta radicale?
Alla prima domanda va aggiunto un altro aspetto. Una delle cose che non è stata fatta nella prima fase è quella di procurarsi i dispositivi di protezione individuale, mascherine professionali, camici monouso, guanti. Bisognava procacciarli sul mercato internazionale, oltre a potenziare la produzione nazionale, anche attraverso la riconversione produttiva, facilitando le aziende che producono questi strumenti. Non è stato fatto ed è assolutamente incredibile che oggi ci troviamo senza questi dispositivi, con enormi problemi e rischi ovunque e soprattutto per il personale sanitario.
In Lombardia, superata la prima linea, c’è stato l’impatto sulle strutture ospedaliere, non adeguate a reggere questo confronto. Molti dicono: se fosse capitato in un’altra regione del sud sarebbe stato peggio. Non c’è dubbio, ma tutta questa celebrazione della sanità lombarda va contestualizzata. Si dice che è d’eccellenza poiché dispone di tutti gli strumenti diagnostici immaginabili, c’è accesso a tutte le terapie che sono sul mercato, i suoi ospedali sono coinvolti all’interno di tutte le sperimentazioni Del mondo. Va bene. Ma bisogna aggiungere che molte di queste terapie ed esami diagnostici sono a pagamento, perché nel pubblico i tempi di attesa sono tali che chi può spendere è costretto a rivolgersi al privato e chi non può è costretto a rinunciare alla cura o all’accertamento.
Il servizio sanitario lombardo è centrato in molta parte sulle strutture private, che ricevono circa il 40% della spesa sanitaria della Regione Lombardia. Si tratta di aziende nelle quali non a caso investono banche e fondi finanziari, per trarne profitto.
Quindi, prima considerazione: il privato ha maggiori guadagni quanti più malati ci sono, quanto più c’è da curare. L’impostazione del pubblico è rovesciata: quante meno persone ci sono da curare tanto più risparmia in termini di spesa. L’altra faccia della medaglia dunque è questa: il privato come mission non ha nessuna intenzione di investire sulla prevenzione, perché paradossalmente gli sottrarrebbe clienti e profitti; il pubblico dovrebbe invece avere l’obiettivo fondamentale di investire nella prevenzione per ridurre il numero di persone che giungono alla malattia. Questa differenza di mission non è sempre immediatamente rilevabile, perché, per come è stato definito il sistema sanitario soprattutto in Lombardia, il pubblico ha finito per assumere la logica del privato. Quelle che erano USL (Unità Sanitarie Locali) sono state trasformate in ASL (Aziende Sanitarie Locali): si chiamano aziende e hanno assunto una conseguente logica gestionale da mercato. Nella nomina dei direttori generali, oltre a considerare sempre gli aspetti di vicinanza politica, la Regione valuta i bilanci delle aziende sanitarie; non ragiona sull’efficacia, su quanto hanno abbattuto le liste d’attesa o hanno risposto ai bisogni della popolazione, ma sui bilanci. Il che è assurdo, perché le ASL, come il servizio sanitario nazionale, devono essere sorrette dalla fiscalità generale non dai soldi che si pagano per le prestazioni. Avendo il pubblico fatto propria la logica aziendale e di mercato del privato, diventa difficile misurare quella fondamentale differenza di obiettivo. Tra l’altro, il pubblico ha ridotto ai minimi termini i servizi di prevenzione sul territorio, dai centri per la medicina del lavoro alle campagne di informazione per la popolazione. L’Italia è il paese OCSE che destina la percentuale più bassa sulla spesa sanitaria alla prevenzione. Inoltre, il privato investe nella cura nei settori che sono maggiormente produttivi in termini di profitto e quindi non nella prevenzione, molto poco nei pronti soccorsi e nei dipartimenti d’emergenza.
In una ricerca di circa dieci anni fa si rivelava che le strutture pubbliche avevano pronto soccorso e dipartimento di emergenza nel 60-70% dei casi e le strutture private solo in circa nel 30% dei casi.
A questo si aggiunge il taglio dei posti-letto. Nel 1981 i posti letto nella sanità erano 530.000, nel 2017 sono meno di 230.000. Infine, vi è la carenza di medici, dovuta al numero chiuso nella facoltà e al ridotto numero di specialità, anch’esse con numero chiuso. È così che siamo giunti a una cronica situazione di difficoltà, evidenziata drammaticamente dall’attuale emergenza pandemica.
Sì, è vero che i provvedimenti presi dal governo italiano finiscono con il portare altri fondi al privato. Era giusto – e abbiamo insistito in molti su questo – che il privato, a cominciare da quello convenzionato, fosse immediatamente coinvolto nell’impegno per contrastare la diffusione del virus. Com’è avvenuto però questo coinvolgimento? Con un ampliamento dei meccanismi di accreditamento di convenzione tra pubblico e privato. Se prima erano necessarie settimane o mesi per accreditare un privato, adesso avviene in pochi giorni. Questi accreditamenti scompariranno superata l’emergenza del Coronavirus? Sono convinto del contrario e quindi vedremo aumentato il peso del privato convenzionato dentro il servizio sanitario.
Con la delibera dell’8 marzo della Regione Lombardia è stato detto che il pubblico e il privato accreditato possono cancellare le visite e gli esami che non sono ritenuti urgenti, cioè che non sono da svolgere entro dieci giorni. Bene, si sono cancellate migliaia di appuntamenti e la gente dove si è rivolta? Al privato, che realizza così nuovi ingenti guadagni.
Personalmente, ho sostenuto che andavano obbligate tutte le strutture private non convenzionate a fornire le prestazioni cancellate dal pubblico causa l’emergenza; il pubblico avrebbe poi rimborsato il costo equivalente a quello che avrebbe pagato il servizio sanitario per svolgere quella funzione. Ipotesi che non è stata presa nemmeno in considerazione. Per cui è vero: questa gestione dell’emergenza Coronavirus alla fine ci farà trovare gli equilibri ancor più spostati a vantaggio sia del privato convenzionato che del privato tout court.
Si parla in questi giorni, sull’onda e per le necessità della crisi economica correlata e conseguente a quella sanitaria, di nazionalizzazione. È pensabile si possa proporre e arrivare a una nazionalizzazione di alcuni segmenti della farmaceutica e della strumentazione medica?
Più che arrivare a processi di nazionalizzazione del settore farmaceutico, obiettivo corretto ma di difficilissima realizzazione, è necessario rivedere totalmente l’organizzazione del servizio sanitario nazionale. Io credo si debba aprire un grande dibattito su come mai non è stato in grado di rispondere ai livelli necessari all’emergenza del Coronavirus, pertanto comprendere sino in fondo l’importanza di un servizio sanitario universale, fondato in gran parte sulla prevenzione, perché nel futuro arriveranno altre situazioni di questo tipo, altre analoghe epidemie; perciò va rivista l’organizzazione del nostro servizio pubblico.
Dev’essere maggiormente finanziato, perché i fondi sono stati tagliati in modo incessante negli ultimi decenni, ma all’interno delle risorse dev’essere fortemente aumentata la quota destinata alle strategie di prevenzione. Dev’essere potenziato anche il rapporto con la popolazione, dobbiamo andare verso un’impostazione della cura e della prevenzione che non sia solo una delega al servizio sanitario, ma veda un protagonismo dei cittadini. Non dimentichiamoci che la legge di riforma sanitaria italiana del 1978 prevedeva, per esempio, che ci fosse un ruolo svolto dai sindaci, dai comitati delle popolazioni anche nel controllo del funzionamento dei servizi pubblici. Bisogna ridare ai cittadini almeno parte della titolarità sulla propria salute.
Guardando indietro, c’è tutto un filone di pensiero al riguardo, pensiamo ad esempio a Ivan Illich, secondo cui il benessere della popolazione è dato dall’intreccio tra la consapevolezza del proprio stato di salute, di ciò che è necessario per salvaguardarlo e le capacità del mondo sanitario.
Per quanto riguarda la farmaceutica, la situazione è molto complessa. Certo, sarebbe necessario avere un’industria pubblica, che è stata invece smantellata. Io vedo però molto difficile una nazionalizzazione a livello di singolo paese, servirebbe un’industria farmaceutica pubblica sul piano europeo. Questo perché tutte le ricerche, i trial e le sperimentazioni ormai non vengono più gestite a livello solo nazionale. Mi rendo conto che è difficilissimo, un libro dei sogni. Tuttavia, sono possibili obiettivi intermedi. Devono essere modificate totalmente le regole, a cominciare dalla modifica dei regolamenti TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, rivedendo la logica dei brevetti. Oggi un’azienda ha l’esclusiva del brevetto per vent’anni; vuol dire che può produrre solo lei quel farmaco e ne può stabilire il prezzo sul mercato senza che vi sia alcuna alternativa.
Poi vanno rivisti i rapporti tra gli stati e le aziende farmaceutiche; non parliamo dei comportamenti dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e della CUF (Commissione Unica per il Farmaco). Io sto seguendo tanti casi dove, da un giorno all’altro, le aziende farmaceutiche ritirano un prodotto, lasciano la popolazione senza quel medicinale perché ne stanno per lanciare un altro, che non ha nulla di nuovo se non il nome e che viene messo però nella fascia pagamento. Prima che intervenga l’AIFA passano mesi e va detto che in tantissimi casi l’atteggiamento dell’Agenzia è totalmente subalterno alle multinazionali. Allora, qui si tratta di prendere provvedimenti sull’incompatibilità dei ruoli, sul ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità e nei controlli delle sperimentazioni… Si tratta di avere leggi adeguate, ma anche di fare anche un po’ di pulizia all’interno di queste istituzioni.
Le misure di distanziamento sociale, l’esercito per le strade, i controlli attraverso la geolocalizzazione, l’allineamento dei media. Si sta andando verso un modello cinese di governo sociale? Tutte queste misure erano e sono inevitabili? C’è il rischio che, superata l’emergenza, queste forme e strumenti di controllo e disciplinamento permangano?
Le misure che sono state assunte sono necessarie, al di là degli aspetti più mediatici. Ci sono contraddizioni, evidentemente. Che senso ha dire che ci vuole l’esercito nelle strade e poi dire che centinaia di migliaia di persone devono continuamente andare a lavorare per svolgere lavori che non sono essenziali per la sopravvivenza della popolazione? Da una parte si sceglie l’impatto fortemente mediatico e dall’altra ci si accoda agli interessi del profitto.
Se ci sia poi il rischio che, dopo l’emergenza, queste forme e strumenti di controllo e disciplinamento permangano, io mi auguro ovviamente di no. Il rispetto delle misure da parte della popolazione implica un grande senso di collettività, comporta il capire che la difesa della nostra salute dipende da ciascuno di noi, che si è responsabili non solo per sé stessi ma anche verso gli altri. Implica sviluppare un sentimento per cui ci si sente comunità, collettività. Questo stesso sentire, la considerazione per il benessere collettivo, deve poi portare a dire che le situazioni di emergenza non possono essere usate per modificare la nostra vita quotidiana, la Costituzione concreta. Ciò dipende da come la popolazione, ma soprattutto la sua parte più attiva, la società civile organizzata, vive queste misure, con quale spirito e logica; quindi una volta terminata l’emergenza è necessario assolutamente ristabilire le regole della vita democratica.
Che consigli, sui diversi piani, è in grado di dare ad altri paesi, come la Spagna, che sembra avviata a un’escalation e una drammatizzazione dell’epidemia analoga a quella italiana?
La Spagna, come gli altri paesi, non deve seguire l’esempio italiano soprattutto nella prima fase della gestione dell’epidemia. Noi ci troviamo senza dispositivi di protezione individuale ma perfino senza farmaci. Anche qui è necessario un intervento diretto e severo del governo, che obblighi le aziende farmaceutiche ad aumentare la produzione, a modificarne le linee, attivando un meccanismo di riconversione in tempi brevissimi per aumentare la produzione dei farmaci necessari. Bisogna obbligarle a livello europeo a mettere sul mercato i farmaci a un costo diverso da quello attuale, perciò superando il brevetto.
Gli stessi accordi TRIPs sulla proprietà intellettuale prevedono che, di fronte a una emergenza sanitaria ed economica, i governi possano non rispettare le norme sui brevetti. Sono meccanismi complessi, ma se assunti a livello europeo possono aiutare nell’approvvigionamento dei farmaci senza che si crei un problema ulteriore sui costi.
Mi pare che la Spagna si sia mossa positivamente su un punto importante, poiché ha dichiarato immediatamente che le strutture sanitarie private possono essere requisite se la struttura pubblica ne avesse bisogno. Questa è una misura che in Italia non c’è. In un decreto si accenna tale possibilità ma non si specifica se si fa riferimento solo a strumenti sanitari o anche alle cliniche, agli immobili. In ogni caso, nella pratica non è stata realizzata.
C’è una questione più di fondo. Una sanità che è impostata sul profitto privato smantella tutto quello che è intervento di prevenzione e demolisce la medicina primaria, svalutando il ruolo dei medici di base, perché così i cittadini si rivolgono direttamente a specialisti e strutture private. Non è una cosa che nasce oggi, sono decenni che continua. Ad agosto scorso, il numero due della Lega, nel precedente governo, disse che i medici di famiglia appartenevano al passato e che la gente ormai andava su Internet per scegliere uno specialista cui rivolgersi. Attualmente, in Lombardia la Lega governa con Forza Italia l’emergenza in corso. Dietro le carenze e i provvedimenti errati che sono stati assunti ci sono, insomma, una logica, un calcolo e un pensiero politico che hanno condotto a tutto ciò.
* Intervista realizzata da Orsola Casagrande e Sergio Segio. Una versione ridotta di questa intervista è pubblicata in dato odierna sul quotidiano basco Berria – qui scaricabile in 2 .pdf
Allegati scaricabili
-
 agnoletto-berria.p1
agnoletto-berria.p1
Dimensione del file: 232 KB Download: 218 -
 agnoletto-berria-p2
agnoletto-berria-p2
Dimensione del file: 104 KB Download: 208
Related Articles
Ora partiranno le cause civili per i risarcimenti dei manifestanti
![]()
Il reato di lesioni, con aggravanti, è stato prescritto. Decisiva la legge berlusconiana Cirielli
Pandemia. L’Oms: in Europa «più casi e morti del resto del mondo»
![]()
Ieri toccati nuovi record di vittime e di casi. Dalla Cina medici e materiale sanitario
Tre leggi per i diritti umani
![]()
Con una sentenza all’inizio dell’anno la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l’Italia per trattamenti disumani e degradanti, in relazione allo stato delle carceri. L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare le condizioni dello stato di diritto e l’osservanza della Costituzione. Il presidente Napolitano ha definito il sovraffollamento carcerario una questione di «prepotente urgenza» e di recente ha rivolto l’ennesimo invito perché siano approvate misure strutturali per porre fine alle disumane condizioni delle carceri.





Molto bella l’intervista di Vittorio Agnoletto. Ottimo lavoro il vostro