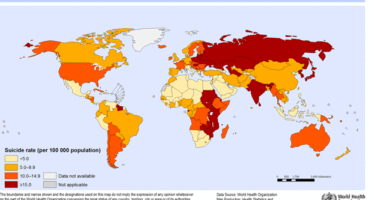Quartiere è Potere
![]()
Quando i gay di San Francisco tra il 1980 ed il 1985 hanno cominciato ad espandersi dal quartiere di Castro a quelli vicini, la Mission Discrict abitata dai latinos, la Fillmore tradizionalmente nera, si è sentito per la prima volta parlare di “gentrification”, un neologismo che vuol dire letteralmente “imborghesimento”, essendo la “gentry” la “gente per bene”, anzi per esattezza «gente con una buona posizione sociale vicina ma inferiore a quella della nobiltà ». I gay, in piena ascesa sociale allora – poco dopo sarebbe scoppiata l’Aids decimandone e impoverendone la popolazione – volevano abitare in quartieri “chic”, col verde ben curato, una buona dose di sicurezza per strada, e negozi e boutique che riflettessero il loro gusto quello “slick” che in italiano significa un po’ “leccato”. I neri e i latini reagirono e a volte violentemente. L’Aids bloccò tutto, ma verso la fine del secolo apparvero nuovi ricchi, i “dot.com”, i giovani di Silicon Valley che avevano fatto un sacco di soldi con la rivoluzione informatica. Comprarono le case della Mission e di Fillmore al primo prezzo richiesto loro e uccisero per sempre quelli che erano stati i quartieri della bohème vera di San Francisco. La bolla immobiliare creata da loro fece lievitare talmente i prezzi che buona parte dei ristoranti e dei negozi, delle gallerie d’arte e dei posti che facevano musica chiusero. E la città nel suo insieme divenne un dormitorio per annoiati pendolari tra la Silicon Valley e San Francisco. Questo è un processo tipico della gentrification, secondo la definizione che la sociologa Ruth Glass ne diede nel 1964, una invasione dei quartieri della working class da parte delle classi medie. Ne rimane fuori però la
molla scatenante. Perché i “borghesi” vogliano trasferirsi in un quartiere un po’ malandato e popolare ci vuole l’effetto che solo recentemente – una decina di anni fa – è stato definito “creative city”.
La borghesia è attirata dalla vitalità dei quartieri più poveri, ma creativi, quelli dove ci stanno ancora i posti in cui si mangia bene, l’atmosfera è informale e per le strade c’è gente, artisti, musicisti, giovani, nullafacenti, e gente che si inventa maniere di vivere un po’ diverse o le ha per tradizione. A Parigi può essere la zona di Menilmontant o di Barbes, a Roma la Trastevere di un tempo e il Pigneto di oggi, a Milano via Paolo Sarpi o il quartiere Isola. Ma la borghesia alla fine detesta proprio i motivi per cui è attirata da un quartiere: vuole i locali, ma poi non vuole essere disturbata nel sonno, vuole l’animazione, ma non vuole vederne troppa, vuole la multietnicità , ma ne ha paura. E allora l’effetto “creative city” si trasforma presto in città dormitorio. La gentrification finisce per uccidere ciò che ama. È quello che sta succedendo a Berlino, non solo nel quartiere molto vivo di Kreuzberg, tradizionalmente uno dei più poveri della ex Berlino Ovest, ma in tutti i quartieri della ex Berlino Est come Mitte che fino a poco tempo fa erano considerati “limite” dove affitti bassi, difficoltà di accesso ed una popolazione mista di immigrati e giovani anarchici e post-hippie avevano inventato una maniera di vivere piuttosto sperimentale. Il Guggenheim finanziato dalla BMW voleva installare a Kreuzberg una architettura provvisoria ideata dall’atelier Bow-Wow e i propri laboratori ma questo ha suscitato le proteste della popolazione che vi vedeva una mossa da “gentrification”. Alla fine le proteste hanno avuto successo – niente
architettura provvisoria, ma un laboratorio fiume da oggi al 25 luglio su “Come fare le città “, con dentro tutte le tematiche scottanti, gentrification, smart cities, partecipazione, governance. A Berlino si sente che il successo della città delle gallerie d’arte e della mondanità ha ucciso la parte più dark, trasgressiva, underground della città . La città attira il turismo in cerca di posti trendy, ma si trasforma in un posto sempre più per bene. Se questo è un esempio del problema però è vero che le cose spesso sono più complicate.
Uno dei casi tipici è Barcellona, la Barcellona di fino a sei anni fa, di quando tutti i giovani europei volevano andarci a stare, una zona franca di libertà , simpatia, convivialità e pazzia. L’origine era il modo con cui la città aveva affrontato il dopo-Franco, dandosi una configurazione pensata proprio in funzione di un rilancio internazionale. Un
grande sindaco, un gruppo geniale di architetti avevano “risanato” il centro storico, luogo di una secolare miseria, ma anche di una intensissima vita popolare, avevano creato un lungomare ed una spiaggia, interrato le arterie di grande traffico, offerto alle imprese immobiliari l’occasione di costruire, se provvedevano anche al decoro degli spazi pubblici. Ovviamente si trattava di “gentrification” e una parte della gente – dei poveri – che abitavano nel centro storico se ne dovettero andare, non perché cacciati via, ma perché il costo della vita si era improvvisamente quintuplicato. L’effetto è stata una Barcellona bella, internazionale, ma che consumava ad un ritmo veloce proprio i valori che propagandava: la convivialità distrutta dall’arrivo di troppi turisti, la vita di quartiere devastata dai nuovi compratori, i tradizionali luoghi di ritrovo trasformati in “tiendas” chic e care.
Chi ha sbagliato? Tutti e nessuno: la gentrification risponde all’esigenza di rendere le città più vivibili, meno degradate, ma è vero che questo processo di
upgrading
inevitabilmente elimina le opportunità che un quartiere povero e popolare offre a chi ci sta. La “bohème” o come la chiamano oggi i comunicatori “la creative city” ha sempre attirato quelli che pensano di poterla comprare, ma che non dormirebbero mai nella soffitta di Mimì. È la dialettica tra rinnovamento urbano e conservazione sociale, una dialettica difficile da gestire in modo che non si trasformi in un meccanismo distruttore. Josip Acebillo, l’architetto geniale che di Barcellona è l’inventore, sa di avere creato un po’ un mostro che alla fine è crollato con l’esplosione della bolla immobiliare. Eppure viene chiamato a ripetere l’esempio Barcellona a Singapore, in Russia, negli Emirati. E oggi come
non mai il verbo delle “creative cities” e delle “smart cities” non fa altro che inventare altre definizioni per una questione che rimane aperta. “Smart city” sarebbe una città “eco-sostenibile”, “socialmente innovativa”, “partecipativa”, che ha risolto i problemi della mobilità e quelli della conflittualità e che ha un governo misto pubblico-privato. Tutto molto interessante, ma il verbo rimane sempre innovazione e questa spesso si scontra con i valori prodotti da chi già ha abitato la città , rendendola un posto bello e vivibile. Le città sono creative e furbe se mantengono quel condensato di vita sociale informale e autoprodotta che soltanto i quartieri ad alta densità – rapporti vis-à -vis, botteghe artigianali, bambini che giocano per strada, presenza di anziani fuori dalla porta, mercati e cibo all’aperto, panni stesi ad asciugare – possono assicurare. Shanghai e Pechino sono l’esempio di
come il potere centrale e il nuovo vangelo dell’arricchimento condanna proprio gli “utong” e gli “shikumen”, i vicoli e le strade della Cina conviviale e popolare. E nello stesso tempo cancella quello che invece riconosce come un patrimonio, almeno dal punto di vista turistico. Che soluzioni ci sono? Probabilmente una ridefinizione di “rinnovamento urbano” che tenga conto della necessaria componente di compattezza e densità sociale. Anni fa mi ero battuto perché qualcuno calcolasse il valore aggiunto prodotto dall’abitare bene – socialmente, collettivamente – un posto. La gentrification è attirata proprio da quel valore, da quella che io chiamo “Mente Locale” la relazione di identità tra abitanti e luoghi dell’abitare. È questa la ricchezza prodotta da una città che non deve essere spazzata via dalla gentrification.
Related Articles
Rapporto OMS. Il tasso di suicidi nel mondo
![]()
Secondo il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato il 4 settembre, ogni anno 800mila persone muoiono a causa di un suicidio
“Education First” nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia
![]()
 Il segretario Onu Ban Ki Moon – Foto: facebook.com
Il segretario Onu Ban Ki Moon – Foto: facebook.com
Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea Generale dell’Onu approvò all’unanimità la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Trent’anni prima, esattamente nello stesso giorno, l’Organizzazione aveva adottato un’omonima, ma non vincolante, Dichiarazione. La scelta di questa data come Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, dunque, appare obbligata, a rimarcare sia i progressi raggiunti che il molto lavoro da fare.