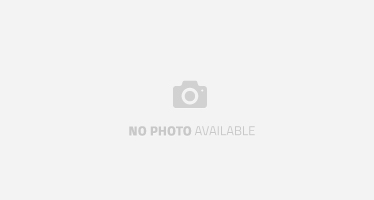Il professore, il filosofo e l’archivio ritrovato
![]()
La circostanza più paradossale, per un ossesso del linguaggio come Wittgenstein, che ha nella sua scarna bibliografia l’inespugnabile Note sul colore, è che si almanacchi ora sulla natura cromatica di un suo scritto ritrovato. «Può essere, come no, l’opera mancante chiamata Libro rosa o Libro giallo che gli studiosi cercano da tempo», commenta Arthur Gibson, l’uomo che ha trascorso gli ultimi tre anni su un colossale archivio inedito di uno dei più complessi e decisivi filosofi del Ventesimo secolo. Il professore di Cambridge si riferisce a un quadernetto da scolaro dalla copertina rosata che contiene nuovi testi del logico viennese. Un oggetto del desiderio per gli specialisti, forse il seguito ideale – seppur anteriore – delle Ricerche filosofiche con cui nella seconda parte della sua vita aveva demolito il Tractatus logico-philosophicus.
Chissà come avrebbe commentato lui («su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere») di fronte a questa confusione di tonalità . Tuttavia sarebbe contento del rinvenimento del tesoretto da 150mila parole che contiene, oltre alla perla suddetta, l’unica versione vergata a mano del Libro marrone, ovvero appunti delle sue lezioni a Cambridge a metà degli anni Trenta. Con una sessantina di pagine aggiuntive e un’introduzione rivista. Oltre a un migliaio di calcoli matematici in cui l’allievo poi contestatore di Bertrand Russell si misura anche con il Piccolo problema di Fermat, in una dimostrazione lunga sei metri se si mettessero in fila i fogli. «È come se si fosse creduto di conoscere tutto il Dna e venisse fuori che ce n’era ancora un quarto ignoto. Oppure scoprire sia nuove opere che diversi arrangiamenti di Puccini. Quando ho aperto quelle scatole sono rimasto senza parole», confessa il curatore, «un intero mondo di manoscritti mai letti prima che aprono uno squarcio sui suoi processi mentali. Confrontando versioni, correzioni e aggiunte è come vedere il suo cervello all’opera».
Uno spettacolo, considerato il titolare della testa. Con tanto di illustrazioni e glosse sugli appunti che dettava al suo amanuense, nonché giovane amante, Francis Skinner. Nello spartano studio nella Great Court, dove Wittgenstein insegnava e Newton aveva vissuto, non c’era nient’altro che una sedia a sdraio, una stufa e Francis. «Il suo ruolo intellettuale esce molto rafforzato da queste carte, erano uno lo specchio dell’altro» spiega Gibson, «nei suoi confronti il filosofo aveva una relazione quasi bipolare, tra fortissima vicinanza emotiva e rigetto. Un amore-odio che già aveva provato verso il padre miliardario e ingombrante. E il fratello Paul, pianista di genio nonostante avesse perso un braccio in guerra, che non amava la sua filosofia più di quanto lui sopportasse la sua musica. Il numero degli studenti che aveva cacciato dalle lezioni cresceva di giorno in giorno. Alla fine in classe era rimasto solo lui».
Quel che non riuscivano a fare all’università lo finivano a casa. Convivevano, nonostante l’omosessualità fosse reato. Studiavano russo e vagheggiavano di trasferirsi in Unione Sovietica, abbandonando la filosofia per darsi alla medicina o all’allevamento. Indifferentemente. Così, quando nel ’41 la poliomelite uccide l’allievo, il maestro rischia di impazzire. Considera di lasciare l’insegnamento. E per sbarazzarsi dei ricordi spedisce per posta i tre pacchi di appunti a Reuben Goodstein, amico di Francis e suo studente. «Questi si impegna», spiega Gibson consegnando a Repubblica la copia della lettera, «a contattare il filosofo se avesse trovato materiali pubblicabili. E oggi, di fronte a testi di tale importanza resta il mistero del perché non l’abbia fatto».
Qui la trama epistemologica si intorbidisce di umanissime pulsioni. Da una parte il custode era stato vicino a Skinner, dall’altra venerava Wittgenstein («sua moglie ne era tanto gelosa da proibire che se ne pronunciasse il nome in casa») e potrebbe aver sottovalutato per rivalità la rilevanza degli scritti. Così si spiegherebbe forse il lungo letargo ermeneutico, continuato anche quando nel ’76 li affiderà alla Mathematical Association. Per concludersi infine negli ultimi anni, con la presa in cura di Gibson al Trinity College.
Nel sessantennale della sua morte lo Schwules Museum di Berlino gli dedica una mostra piena di diari e oggetti, compresa la leggendaria giacca di tweed grigio di tante foto, mentre Sotheby’s batte a quattromila sterline di base d’asta anche gli appunti minori scritti sul retro delle lettere del fratello. Pochi pensatori possono vantare inversioni a U tanto radicali e tuttavia convincenti nel proprio tragitto intellettuale. Il Wittgenstein 1.0, quello del Tractatus (1921), studia la lingua come modo per conoscere. Solipsisticamente dice: «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo». Al di fuori non c’è niente, dal momento che non si può dire. Il Wittgenstein 2.0 invece si concentra sulla sua natura più sociale, di strumento di comunicazione. è come se fosse uscito dalle trincee della Grande guerra e dal campo di prigionia italiano dove aveva terminato il Tractatus per mischiarsi col mondo.
Molte delle riflessioni che poi confluiranno postume nelle Ricerche (1953) sono concepite nello stesso periodo delle carte ritrovate. In quegli anni sostiene che il linguaggio va studiato non nella sua dimensione astratta (come di «ghiaccio puro») ma nei suoi usi pratici («la terra ferma»). Spiega Gibson: «Da quest’archivio si capiscono cose che illuminano meglio anche scritti successivi. Che la verità per lui non è auto-evidente. Anzi, ciò che sappiamo spesso ci confonde sulla nostra reale ignoranza. Un po’ come illudersi che conoscere le previsioni del tempo per oggi ci dica qualcosa su come sarà tra un mese. E ancora, pur abbandonando l’idea della filosofia come sistema, è come se volesse ricomporre le due parti del suo pensiero. Nelle profondità dell’uso ordinario del linguaggio, straordinariamente preciso e al contempo sorprendentemente arbitrario, vedeva somiglianze con la matematica pura avanzata. Nel solco delle Ricerche voleva indagare proprio i legami tra matematica e lingua, sostenendo che è dal loro incontro che deriva la logica. Che non si può estrarre dalla matematica soltanto, seguendo invece Russell e Frege». Che sia il Wittgenstein 2.1 o addirittura 3.0, resta la nuova entusiasmante puntata di un film teoretico dal finale ancora aperto.
Related Articles
L’assalto al cielo del «matto» Antonelli
![]()
Si è tornati a parlare, all’inizio di quest’anno, dell’architetto Alessandro Antonelli, nato a Ghemme in provincia di Novara nel 1798 e noto soprattutto per aver progettato due edifici: la cupola di San Gaudenzio a Novara e la Mole a Torino, interamente in muratura, in un’epoca in cui la nuova tecnica del cemento armato permetteva di raggiungere altezze precedentemente impensabili.
Il monopolio del libro
![]()