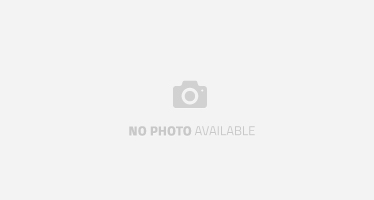Omaggio a Carlo Bo il saggio che spiegava la vera letteratura
![]()
Nei giorni scorsi a Urbino si è tenuto un convegno per celebrare Carlo Bo nel centenario della nascita. E protagonista è stato, inevitabilmente, il Carlo Bo lettore: di Leopardi, di Proust, di Kafka… Qualche anno fa Sergio Pautasso mise insieme un’ampia antologia degli scritti di Bo e la intitolò Letteratura come vita, che era poi il titolo di una relazione tenuta da Bo nel 1938 al V° Convegno degli scrittori cattolici. Argomentava Bo: «Rifiutiamo una letteratura come illustrazione di consuetudine e di costumi comuni, aggiogati al tempo, quando sappiamo che è una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza».
Il discorso di Bo, pubblicato nel volume intitolato Otto studi fece discutere, anzi Mario Alicata lo prese di petto, anche se Bo stesso aveva chiesto, in una nota a margine, di guardarsi bene dal prendere quel testo per un manifesto o simili. Il valore vitale della letteratura è oggi decisamente offuscato dal suo valore venale che naturalmente l’industria culturale privilegia, preferendo di gran lunga l’informazione alla critica.
Se ne era già accorto lo stesso Bo in uno scritto dei primi anni Sessanta, prevedendo una diminuzione degli spazi assegnati al critico, il che è puntualmente avvenuto, non solo in ambito letterario. Nel campo delle arti visive, per esempio, la figura del “curator”, che è poi soprattutto un manager, tende a sostituire quella del critico.
Ma che critico era Carlo Bo? Lo racconta Jean Starobinski nella prefazione scritta apposta per l’antologia prima citata. Albert Thibaudet, scriveva Starobinski, aveva distinto tre tipi di critica: la militante, che dava conto delle novità , l’accademica che studiava stili e problemi con un respiro più ampio e infine la critica dei maestri, ovvero degli scrittori e dei poeti. Bene, conclude Starobinski, «Mancava in questo quadro la categoria del saggio che riunisce in una sintesi libera le tre attitudini di cui sopra». Bo si collocava dunque in questa “quarta dimensione”, che non era né militante né accademica, diventando la sua scrittura «una sorta di diario personale (intimo e non) sempre aperto».
Related Articles
«Anna Karenina», esperimenti di realtà simulata
![]()
Bella scoperta, viene da dire leggendo sul «New York Times» quello che scrive la giornalista Annie Murphy Paul in un articolo intitolato Your Brain on Fiction.
PENGUIN SI LANCIA NEL LIBRO FAI-DA-TE
![]()